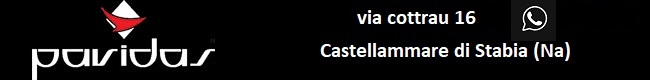


Il Primo Maggio è una festa ormai osservata pressappoco in tutto il mondo e che si lascia alle spalle una lunga scia di sangue, di soprusi, di sfruttamento soprattutto dei minori, di insofferenze e incomprensioni tra imprenditori, impresari e forze lavorative sostenute queste ultime dalle nascenti organizzazioni sindacali. L'origine dell'importante "Festa" e cambiamento del mondo del lavoro, che ha segnato impensabili progressi sociali, risale praticamente al 1882, fu istituita negli Stati Uniti dai Cavalieri del Lavoro (Knights of Labor, associazione fondata nel 1869). L'idea nacque dopo una manifestazione, organizzata sempre dagli stessi "Cavalieri", in cui venivano posti energicamente sul tappeto i complessi problemi del mondo del lavoro. Nel 1884, in un'analoga manifestazione sempre i "Cavalieri" approvarono una "risoluzione affinché l'evento avesse una cadenza annuale". Altre organizzazioni sindacali affiliate all'Internazionale dei lavoratori - vicine ai movimenti socialisti ed anarchici - suggerirono come data della festività il primo maggio. Più precisamente, con essa si intendono ricordare le battaglie operaie volte alla conquista di un diritto ben preciso: l'orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il r.d.l. n. 692/1923). Tali battaglie, come ricordano gli storici, portarono alla promulgazione di una apposita legge che fu approvata nel nell'Illinois (USA). La Prima Internazionale richiese poi che legislazioni simili fossero introdotte anche in Europa.
La scelta su questa data furono i gravi incidenti accaduti nei primi giorni di maggio del 1886 a Chicago. Qui, il 3 maggio i lavoratori in sciopero si radunarono all'ingresso della fabbrica di macchine agricole McCormick. La polizia, sollecitamente chiamata a reprimere l'assembramento, da chi aveva interesse a soffocare sul nascere la protesta, sparò sui manifestanti uccidendone due e ferendone diversi altri. Per protestare contro la brutalità delle forze dell'ordine gli anarchici locali organizzarono una manifestazione da tenersi nell'Haymarket square, la piazza che normalmente ospitava il mercato delle macchine agricole. Questi fatti ebbero il loro culmine il 4 maggio quando la polizia sparò nuovamente sui manifestanti provocando numerose vittime, anche tra i suoi.
Nel 1887, l'11 novembre, sempre a Chicago, quattro operai, organizzatori sindacali e quattro anarchici furono impiccati per aver organizzato il primo maggio dell'anno precedente lo sciopero e una manifestazione per ottenere le otto ore di lavoro settimanali.
Il 20 agosto fu emessa la sentenza del tribunale: August Spies, Michael Schwab, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Adolph Fischer, George Engel e Louis Lingg furono condannati a morte; Oscar W. Neebe a reclusione per 15 anni. Otto uomini condannati per essere anarchici, e sette di loro condannati a morte. Le ultime parole pronunciate furono: Spies: "Salute, verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che oggi soffocate con la morte!" Fischer: "Hoc die Anarchie! (Viva l'anarchia!)" Engel: "Urrà per l'anarchia!" Parsons, la cui agonia fu terribile, riuscì appena a parlare, perché il (boia) strinse immediatamente il laccio e fece cadere la trappola. Le sue ultime parole - dicono i testimoni - furono queste: "Lasciate che si senta la voce del popolo!"
Sostanzialmente, come ricordano i cronisti dell'epoca e gli storici, sono questi i fatti che hanno rivoluzionato il mondo del lavoro e quindi della società per il raggiungimento di un progressivo benessere della collettività.
In Italia, appena si diffuse la notizia dell'assassinio degli esponenti anarchici di Chicago, nel 1888, si ebbero le prime reazioni, in modo particolare a Livorno, dove gran parte della popolazione si rivolse prima contro le navi statunitensi ancorate nel porto, e poi contro la Questura, dove si diceva che si fosse rifugiato il console USA.
Tuttavia, in Italia la festività fu soppressa durante il ventennio fascista - che preferì festeggiare una autarchica Festa del lavoro il 21 aprile in coincidenza con il Natale di Roma - ma fu ripristinata subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1945 (interessantissimi gli studi dello storico stabiese Gabriele De Rosa, già rettore dell'Università di Salerno).
Nel 1947 la fausta ricorrenza venne funestata a Portella della Ginestra, quando la banda di Salvatore Giuliano sparò su un corteo di circa duemila lavoratori in festa, uccidendone undici e ferendone una cinquantina.
Dall'anno 1990 i sindacati italiani CGIL, CISL e UIL organizzano annualmente a Roma l'ormai divenuto famoso concerto per celebrare il Primo Maggio cui partecipano ogni anno centinaia di migliaia di persone. Nel 2011 si contarono circa ottocentomila partecipanti convenuti da ogni parte d'Italia.
Per comprendere meglio il clima di euforia, giustificato dalle enormi conquiste ottenute dai lavoratori, la Rivista forlinese "La Rivendicazione", così scriveva nel numero del 26 aprile del 1890: "Il primo maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo, è parola d'ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento".
Un passo indietro, ora, per ricordare, soprattutto ai giovani, che il processo di trasformazione si può dire di tutta la società italiana, va valutato in una sfera di miserabili condizioni di vita in cui vivevano le nostre popolazioni, particolarmente giovanili, che venivano barbaramente sfruttate dai datori di lavoro per lunghissime ore al giorno in opifici e fabbriche con ambienti spesso malsani. In un articolo, di giornale, necessariamente breve per ragioni comprensibili, non si possono certamente segnare le numerose tappe di un processo evolutivo che caratterizzerà poi quella che chiamiamo formazione del proletariato e organizzazione del movimento operario che sono strettamente legati allo sviluppo dell'industria, la quale, in Italia, si manifestò in ritardo rispetto agli altri paesi europei industrialmente evoluti, quali Inghilterra, Francia, Paesi Bassi, Germania. Vogliamo appena ricordare che le cause principali del degradante stato di cose, vanno ricercate nel mancato funzionamento politico in cui si trovava l'Italia, e il conseguente isolamento economico in cui vennero a trovarsi i vari stati italiani, divisi in oppressivi sistemi doganali. L'accanita forma di protezionismo, infatti, ostacolando la libera circolazione delle merci e dei prodotti finiti, costituiva un frenaggio di ogni azione innovativa, anche nelle stesse regioni più economicamente avanzate come Lombardia, Piemonte, Liguria. In quei periodi mancava ancora una industria meccanica e tutta la produzione del settore era rappresentata da una pullulazione di piccole officine a conduzione familiare e a livello artigianale. E' l'epoca in cui si formarono i primi nuclei di proletariato con una diffusione abbastanza ampia proprio alla vigilia dell'unità e in quelle stesse regioni, sufficientemente sviluppate, dove esisteva una tradizione secolare della lavorazione della seta, del cotone e della lana. Nella bottega - laboratorio, c'era ancora il maestro artigiano che lavorava insieme e alla pari con i compagni. Il maestro con i suoi compagni, però andavano scomparendo e avanzava il numero dei salariati perché il mercante, divenuto imprenditore, forniva macchine e materia prima a quanti erano disposti a lavorarla a condizioni economiche più basse, cercando mano d'opera, naturalmente a basso costo, attraverso un ampio reclutamento nelle campagne, dove i contadini per arrotondare i modesti introiti erano disposti, specialmente nei periodi in cui la terra non rendeva, a trasformarsi in operai e a battere per lui i telai insieme con la famiglia. Ciò, rappresentava il primo passo, forse il più concreto, verso la trasformazione delle masse contadine in proletariato urbano. Tale fenomeno, dice lo storico Cafagna, "prepara senza scosse soverchie, il passaggio della famiglia contadina alla maestranza industriale, creando la prima familiarità con i meccanismi dell'opificio, con la vita della fabbrica, avvia l'adattamento complessivo ad una nuova e diversa condizione sociale, rende disponibili gradualmente per l'attività industriale le schiere dei coloni agricoli della fascia pedemontana". Si trattava di una massa operaia, di estrazione rurale che si andava sempre più ingrossando, che cominciava a spingere i cancelli di fabbriche e fabbrichette lombarde, piemontesi, ligure; erano masse di lavoratori un po' amorfe, prive di una coscienza di classe, perché conservava modi di pensiero e di vita contadina, tentando di trasferire nelle città, che per loro apparivano immensi scenari, e la loro differenza dai "signori" si tramutava nel rispetto di chi è scarsamente istruito e preparato. Erano lavoratori che ricevevano salari irrisori in cambio di orari micidiali che si aggiravano dalle 12 alle 16 ore giornaliere. Nella "giungla" che si andava allargando, aumentava la sete di profitti dei datori di lavoro, che naturalmente, come sempre accade, dovevano fronteggiare la continua e progressiva concorrenza e coscienti che le paghe non erano ulteriormente decurtabili, fecero ricorso a mono d'opera femminile molto meno esigente: con la stessa logica venivano reclutati bambini di nove, sette e perfino di cinque anni di età, impiegati in lavori estenuanti, per 12-16 ore consecutive, in locali di occasione, semibui, malsani come possono essere anche quelli dei sottoscale. Tali incredibili condizioni di vita, descritte già nel rapporto dello storico Sacchi del 1842, minavano la salute dei bambini che crescevano linfatici, rachitici e sviluppavano indurimenti ghiandolari, anche perché gli si dava da fumare perché non si addormentassero! Non sfuggivano all'inumano trattamento anche le bambine, seppure meno pressate dalle fatiche, le quali venivano assegnate ad operaie adulte con il compito di girare l'aspo e di mantenere accesi i fornelli. Alle povere malcapitate rimanevano appena cinque, sei ore di sonno quando tornavano a casa per riposare, si fa per dire, su giacigli improvvisati situati in stanze mal ventilate. Dalle cronache del tempo si apprende, ancora, che le bambine più piccole venivano spesso portate al lavoro sorrette dalle madri. Non si contavano maltrattamenti, insulti, abusi, privazioni, invecchiamenti precoci. Si aspetterà la legge del 1886 la quale vietava di "adibire al lavoro negli opifici industriali fanciulli che non avessero compiuto i 9 annie di impiegarne d'età inferiore ai 10 anni in lavori sotterranei". Il numero di morti per cause di lavoro era altissimo, le malattie professionali diffusissime, la tubercolosi minava continuamente la vita dei malcapitati.
Tutto ciò, è quasi superfluo dirlo, era dettato dal potere economico e da quello politico, sempre strettamente legati nelle mani dell'alta borghesia capitalistica che imponeva ai governi (è la storia di sempre!), il suo "comitato d'affari", esercitando sollecitazioni per evitare interventi nel libero gioco della domanda e dell'offerta di lavoro a tutto vantaggio, naturalmente, dell'imprenditore, il più forte, contro gli interessi del prestatore d'opera, il più debole, bisognoso di protezione e di aiuto. Ma si sa, come vanno a finire le cose col passare degli anni: la convivenza, in agglomerati urbani, di più categorie di genti provenienti da esperienze diverse, sollecitò una presa di coscienza per unirsi e lottare contro schiavitù e sofferenze. Era giunto il momento di dire basta ad ogni forma di schiavitù: i numerosi focolai di disordine in tutti i paesi in via di industrializzazione, generarono una continua, ferrea lotta di classe, gettando le basi per tutte le successive battaglie politiche e sindacali e per festeggiare, allora come oggi, conquiste sociali sempre più consistenti. Anche questo Primo Maggio, nonostante tutto, è festeggiato attraverso manifestazioni democraticamente organizzate con la speranza che anche questo particolare momento di crisi sarà superato grazie alla buona volontà da parte di tutti.


Il sorriso del tecnico gialloblù. «Vittoria da squadra vera, ora portiamo questo atteggiamento in trasferta»



-