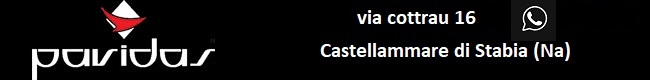


Nei primi giorni di gennaio del 1609, la statua di san Catello era quasi pronta per essere trasportata dalla bottega degli Alamanni da Napoli, a Castellammare di Stabia. Si tratta, come abbiamo detto più volte, di una scultura a forma piramidale (allungata) a base quadrangolare. Fu scolpita sicuramente da un artista formatosi nella seconda metà del Cinquecento in una delle più importanti botteghe specializzate in sculture lignee, quella appunto degli Alamanni (è l'epoca in cui s'iniziano a scolpire migliaia di statue di ogni dimensione per una committenza vastissima che si estendeva anche in altre province). L'opera è stata realizzata da un solo blocco formato da più tavole di legno di tiglio, incollate e fissate in senso verticale. Il Santo si presenta, in ginocchio, poggiato su un cuscino riccamente decorato, in posizione solenne: la testa fiera ed eretta, le braccia incrociate sul petto, veste i sacri paramenti pontificali fra cui si distingue particolarmente il piviale miniato da preziose decorazioni. Quello che colpisce subito è la bellezza della testa. Lo scultore ha effigiato, con arte, un vecchio il cui viso è adornato da una folta barba bianca, dal profilo vigoroso e asciutto che guarda fisso davanti a sé con sacerdotale calma e sicurezza. La barba, divisa in bioccoli lanosi, è stata intagliata piuttosto sommariamente; nonostante ciò, lo scultore, con questi minimi mezzi, con l'esecuzione abbozzata ed incompleta, ha ottenuto un effetto artistico «meraviglioso»: quella barba, vista a pochi metri di distanza, si anima e sembra filamentosa. Gli occhi sono molto belli: realizzati con una pallina di vetro soffiato, novità del Seicento, tagliata in due parti e miniate all'interno, come pure interessante è la bocca semiaperta e incassata in un modo assai naturale tanto da contribuire in senso determinante a conferire all'insieme l'aspetto bonario di un vecchio dolce ma forte. Le mani sono incrociate sul petto. Originariamente erano state scolpite finemente, con le dita affusolate e con le unghie intagliate scrupolosamente e tinte color carnagione. Ma a lavoro compiuto, forse dietro qualche esplicita richiesta da parte delle autorità ecclesiastiche o amministrative del tempo, lo scultore, insieme con il pittore e indoratore, passò una vernice rossa sulla quale furono creati dei filamenti, spezzettati, argentei e bianchi, per cui le mani furono coperte da guanti «di pelle di ariete tinta di rosso» (come hanno sostenuto alcuni autori senza accorgersi che sono ben visibili le forme anatomiche anche delle dita e delle giunture). Il Santo portava alle dita quattro anelli, ma, forse nel rifacimento dei due indici, durante il restauro del 1950 eseguito dal maestro Gustavo Girosi), un anello non è stato rifatto. All'interno della piegatura della mano destra c'era un foro per consentire il passaggio del pastorale (bastone) poi successivamente spostato nella posizione attuale. Tutto il resto del corpo è vestito con i paramenti sacri, anch'essi con sovrapposizioni decorative. La mitra (alta 36 centimetri), fortemente arcuata, lungo il bordo inferiore porta scolpita una teoria di «rosette» a rilievo; queste ultime si notano anche sull'asse mediano della faccia anteriore; risaltano nei lati due fregi ovali di marcato stile rinascimentale. L'amitto (panno, come un grande fazzoletto) che gira intorno al collo e termina in avanti sotto la barba, il camice bianco che scende fino alle ginocchia, terminando con un abbondante panneggio, il cordiglio che lega il camice all'altezza della vita sono bianchi e coperti da una leggera ed elegante ornamentazione in oro a forma di rombi con al centro degli elementi fogliati. Il piviale (mantello) è il capo di abbigliamento che ha impegnato di più sia lo scultore, sia l'indoratore. Infatti, il piviale è ampio e ricade sulla base formando un ricco accartocciamento del tessuto (caratteristica di un certo tipo di scultura di ben individuabili artisti) creando con le pieghe un gioco di riflessi sulle parti aggettanti cui fanno riscontro profonde zone di ombre delle parti incavate. Tutta la decorazione del piviale e della mitra erano ricoperte di oro finissimo ed ancora oggi, dopo il restauro del 1983, risplendono a di stanza di circa quattro secoli. L'artista sulla doratura ha lavorato delle strisce decorate e dei galloni a sottili fregi rossi o azzurri operando sulle superfici di oro delle impressioni a secco rigirate da un fitto punteggio che danno l'idea della stoffa, ravvivando così la policromia dell'insieme. Tutta la decorazione, compreso quello della grossa fibbia - fermaglio, per tenere uniti i due lembi del piviale all'altezza del petto, ricavata dallo stesso legno, è bellissima. Il Santo certamente è inginocchiato su due cuscini: il primo è coperto dai panneggi, mentre il secondo sporge all'esterno e poggia direttamente sulla pedana di base. Anche questo cuscino, con due fiocchi alle punte, presenta una decorazione a «mordente» assai preziosa e vistosa. Altrettanto si deve dire della stola e del manipolo (piccola stola poggiata al braccio) sui quali ci sono richiami decorativi del piviale.
Tutta la statua è alta circa un metro e settanta e quindi, essendo in ginocchio, deve supporsi, per ragioni di proporzioni, che il Santo poggi le ginocchia sul cuscino coperto dal camice.
La larghezza delle spalle è di una quarantina di centimetri mentre la larghezza dell'estremità inferiore risulta di ottanta centimetri). L'insieme scultoreo assume un aspetto volutamente monumentale.
Sicuramente l'artista, è da dire, infatti, per dare al nucleo ligneo una particolare imponenza, non ha potuto osservare rigidamente le proporzioni secondo le regole anatomiche. Crediamo sia utile aggiungere che, nel complesso, la statua si presenta come un prezioso esemplare di quella scultura che rese famose tante «botteghe» napoletane e non pochi artisti del Cinquecento. Mentre «nel campo della pura arte sacra, costituisce un modello di gravità e di solennità senza pari» e risolve, molto probabilmente, il tanto dibattuto problema della policromia nella scultura sacra di quel periodo. Considerata la tonalità abbastanza pacata dell'insieme, risalta solo la colorazione del viso, ottenuta con la tecnica dello sfumato, che, visti i risultati, può essere solo opera di un artista di consumata esperienza. Infatti, questa tecnica si applicava seguendo pazienti "passaggi": l'artista, dopo aver preparato il volto con rifinitura di camicia di stucco, vi passava sopra una mano di minio di piombo, poi una prima e seconda mano di colore ad olio aggiungendo una terza mano di una tinta color carnagione. All'altezza degli zigomi e dove era necessario, il pittore aggiungeva del colore rossiccio. Poi, con un pennello a pelo morbido bagnato in acqua, cominciava a sfumare i colori (sfumatura ad acqua) fino ad ottenere un volto lucido quasi porcellanato.
Cogliamo l'occasione, per aggiungere che la statua di san Catello è stata molte volte restaurata e non sempre da mano esperta. Già nel 1700 si notano larghi interventi sulla policromia e sulla campitura dorata. Rifacimenti di altre parti si sono avute nei secoli successivi.
Nel 1950, dato lo stato di deterioramento del legno, invaso dai tarli, specialmente al volto, si pensò di provvedere ad un intervento di restauro conservativo.
Già mons. Federico Emmanuel stava prendendo l'iniziativa ma poi lasciò la Diocesi. Il suo successore, mons. Agostino D'Arco, nel 1954 affidò l'incarico del restauro al maestro Gustavo Girosi il quale lavorò per circa un anno. Il restauratore rifece il naso, aggiustò le dita, ridipinse le parti più danneggiate. Il restauro costò 60 mila lire. Purtroppo l'opera di deterioramento non si arrestò e, una ventina di anni dopo, in occasione del riattaccamento della testa del Santo che rimase decapitato a causa di un curioso incidente subito. Negli anni Ottanta, infatti, come alcuni ricordano, ma non i giovani ai quali sempre ricordiamo qualche episodio di vita locale (Antonio Ziino, "Il Mattino" 1° maggio 1982), la statua del santo Patrono della città era stata staccata dal corpo da un filo di ferro mentre veniva portata in processione, in occasione della ricorrenza patronale. San Catello stava per rientrare nella sua cattedrale, quando all'altezza dell'Episcopio nuovo, in via Prima de Turris, la testa... ruzzolava sul selciato. Nessuno si era accorto che tra i due lati della strada era steso un filo di ferro sottile, lasciato dagli operai che alcuni mesi prima avevano sistemato delle luminarie... L'arcivescovo del tempo, mons. Antonio Zama, volle affidare l'opera per un consistente restauro della statua ai maestri Antonio e Rosario Lebro, con laboratorio a Napoli, specializzato sia in sculture in legno ex novo che in restauri di sculture lignee o di terracotta di pregevole valore artistico.
La statua di San Catello può essere attribuita alla bottega degli Alamanni in quanto, nei documenti si parla di un certo Giovanni Battista, e la scultura presenta un'impostazione tale da dare l'impressione del gonfiarsi dei panneggi - soprattutto alla base -, creando cosi un gioco di chiaroscuri assai efficace. A complemento di quanto detto, non sfugga poi il fatto che la nostra scultura, presentando elementi comuni ad altre statue site in Chiese napoletane, è molto probabilmente opera della mano di un maestro, la cui formazione non si imposta nel libero scambio del clima nordico (il capostipite Pietro era germanico di origine), ma assimila un certo descrittivismo locale.
Inoltre, non va dimenticato che la bottega (o scuola) degli Alamanni esercitò una influenza secolare sulla scultura lignea napoletana. Gli altri scultori di tale periodo di un certo livello, sono Cristiano Moccia (1549) e figli; Diego de Siloe; Girolamo da Santacroce; Giovanni da Nola (e sua scuola); Michelangelo Noccherino; Francesco Mollica; Benvenuto Tortelli; Bartolomeo Chiarini; Cosimo Fanzago, Diego Ordonez.


Nel primo giorno d’estate, il Parco è stato restituito ai cittadini con l’esibizione degli studenti del Severi, Di Capua e Bonito-Cosenza per la Festa della Musica. Il sindaco: «Lo abbiamo fatto con le scuole, le associazioni e tanta gente. Ora avanti verso il recupero delle acque»



-