Per non dimenticare...
tempo di lettura: 13 min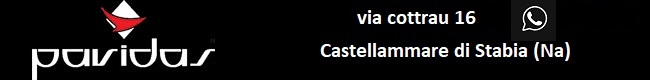


Onore al sen. Sergio Puglia (M5S) che l'anno scorso, 6 agosto 2013, nell'aula sorda e distratta del Senato, ruppe un vergognoso silenzio di 150 anni su una vicenda colpevolmente rimossa dalla coscienza assopita di una collettività retta da una Costituzione che, all'art. 1, retoricamente proclama che il lavoro è il fondamento della nostra repubblica democratica. Ed ora da una lettera del mio amico Gianni, voglio ricordare a tutti i lettori di "Stabia Channel" e del sito "www.unitrestabia.it" quel giorno terribile.
"Nel 1863....i soldati piemontesi entrarono con i fucili spianati nelle officine di Pietrarsa, affollate di lavoratori inermi che scioperavano in difesa del salario e del posto di lavoro, uccidendone non so quanti: una carneficina di cui nessuno sa niente e della quale ormai si va perdendo perfino il ricordo.
Altrove, quei morti, avrebbero mobilitato poeti, scrittori, pittori, politici, giornalisti, storici."
(Ermanno Rea, La dismissione, Rizzoli 2002)
La denigrazione e la menzogna furono le armi più efficaci della massoneria e dei liberali per ben disporre l'opinione pubblica europea alla conquista sabauda del Regno delle due Sicilie ed alla sua riduzione a colonia interna del nuovo stato italiano.
La menzogna più spudorata, per precostituirsi un alibi, fu di descrivere il Regno duosiciliano, appena soggiogato, in una condizione di profonda arretratezza economica, sociale e civile, così da poter sostenere che la questione meridionale non era effetto delle scelte predatorie e discriminatorie immediatamente adottate dai nuovi poteri, bensì già preesistente all'annessione.
Stiamo ai fatti, anche a quelli emersi dal 1° censimento (1861) della popolazione italiana, e vediamo se si può considerare arretrato uno stato che aveva:
- la maggiore ricchezza della penisola, ovvero il 67% dei depositi in oro detenuti da tutti gli stati preunitari;
- il 51% dell'insieme degli addetti all'industria della penisola, avendo il 35% della popolazione complessiva (il primato dell'industrializzazione del nord è solo una favola);
- il maggior complesso siderurgico e metalmeccanico d'Italia, con i poli di Pietrarsa, Mongiana e Ferdinandea;
- la maggiore industria navalmeccanica d'Italia, coi cantieri di Napoli e Castellammare;
- la maggiore flotta mercantile (seconda al mondo dopo quella inglese);
- la più bassa imposizione fiscale;
- il più alto numero di medici per abitanti;
- il più basso tasso di mortalità infantile;
- il primo codice marittimo;
- il primo sistema pensionistico;
- il primo (e più bello) teatro lirico del mondo, costruito in soli 270 giorni.
Potrei continuare a lungo ma temo di tediarvi. Ho tuttavia necessità di soffermarmi (e ne avrete già capito il motivo) sul Real Opificio di Pietrarsa, la prima e più grande fabbrica metalmeccanica della penisola che precede di 13 anni la nascita dell'Ansaldo, di 46 la Breda e di 57 la Fiat.
L'opificio sorse nel 1840 per volontà di Ferdinando II° allo scopo di produrre -affrancandosi dalle importazioni inglesi - macchine a vapore per navi e locomotive e tutto il materiale rotabile (incluse le rotaie) necessario per realizzare, dopo la tratta Napoli-Portici (1839, prima in Italia), la strada ferrata Napoli-Capua e, successivamente, i collegamenti della rete tirrenica con la costa adriatica e ionica.
La fabbrica fu eretta sopra una panoramica superficie lavica di 34.000 mq, sul lungomare susseguente alla spiaggia di S. Giovanni (periferia sud di Napoli), al confine coi terreni della Villa del Principe di Elboeuf, e, quindi, non lontano dalla Villa Reale di Portici.
Essa era in grado di produrre contemporaneamente 8 caldaie da piroscafo o 24 da locomotiva, disponendo di 12 forni, 5 laminatoi (di cui uno per rotaie, unico in Italia), grandi gru, magazzini, biblioteca e una "Scuola d'arte" per formare, carpentieri, fonditori, tornitori e ufficiali macchinisti. Tra gli insegnamenti impartiti: matematica, geometria, meccanica, disegno, architettura, lingue. Anche la scuola fu istituita (decreto del 1841) da Ferdinando II "perché del braccio straniero a fabbricare le macchine mosse dal vapore il Regno delle due Sicilie più non abbisognasse".
La fabbrica nel 1853 aveva 700 dipendenti, saliti a poco meno di 1200 (inclusi gli impiegati) alla caduta del Regno. Tra essi anche 40 detenuti, nell'ambito del primo progetto di reinserimento sociale di reclusi di cui si ha notizia in Italia. Le paghe erano sufficienti a garantire ai dipendenti ed alle loro famiglie una vita più che dignitosa e, per la prima volta in Italia, i dipendenti potevano fruire di una pensione con una lieve ritenuta mensile del 2%.
Lo stabilimento di Pietrarsa divenne in pochi anni famoso in tutta Europa per l' efficienza e la qualità dei suoi prodotti, importati anche da altri stati, compreso il Regno di Piemonte(...). Venne visitato, tra gli altri, da Papa Pio IX e, nel 1845, dallo zar Nicola I° che ne fu tanto ammirato da proporlo a modello per la realizzazione delle officine ferroviarie di Kronstadt, presso Pietroburgo.
Con la conquista sabauda inizia un inarrestabile declino. Il nuovo governo dovette presto decidere se le sue commesse per le ferrovie e le forze armate dovessero privilegiare il più qualificato polo di Pietrarsa o quello neonato dell'Ansaldo di Genova, ma anche gli altri minori che nel centro-nord vittorioso ambivano ad organizzarsi per lucrare sulla spesa pubblica sulla quale potevano influire.
Non fu difficile sciogliere il dilemma: Carlo Brombini, co-fondatore dell'Ansaldo, Governatore della Banca Nazionale ed amico di Cavour, già aveva proposto al governo la dismissione di tutte le imprese del sud, lasciandosi anche sfuggire che i meridionali "non dovranno mai essere più in grado di intraprendere". Ma si decise di dare anche un fondamento "tecnico" ad una scelta politica già presa , per cui si diede incarico all'ing. Sebastiano Grandis (direttore delle ferrovie piemontesi....) di redigere una relazione sullo stato dei due stabilimenti, dalla quale emerse l'opportunità di investire sull'Ansaldo anziché su Pietrarsa, perché, secondo lui, la fabbrica napoletana non consentiva ulteriori ampliamenti. Una valutazione del tutto infondata, considerato che vasti terreni a ridosso dello stabilimento (lato nord e nord-ovest) erano a quell'epoca liberi e lo rimasero fino ai primi del 900.
Il governo Rattazzi, conseguentemente, cedette per il miserrimo canone di 46.000 lire annue Pietrarsa ad un oscuro e spregiudicato imprenditore toscano, tale Jacopo Bozza, che, per prima cosa, soppresse la Scuola d'Arte e in pochi mesi dimezzò i dipendenti, aumentò l'orario di lavoro a parità di salario, pagandolo peraltro sempre più in ritardo.
Il 6 agosto 1863, i 458 dipendenti rimasti, non avendo ancora ricevuto la paga di luglio, decisero di incrociare le braccia fino a quando non gli fosse stata corrisposta. Per tutta risposta il sig. Zimmermann, capo contabile dell'azienda, annunciò altri 60 licenziamenti. Gli operai, esasperati da questo comportamento provocatorio, alle 15,00 si radunarono nel cortile e chiusero il cancello d'ingresso. Il capo contabile contattò allora la questura e, dicendosi preoccupato per "l'atteggiamento minaccioso" degli operai, chiese l'invio della forza pubblica. Poco dopo irruppe una compagnia di bersaglieri che, senza nemmeno cercare di dialogare con gli operai, dettero la carica a quanti presidiavano il cancello, sparando ad altezza d'uomo e colpendo furiosamente con le baionette quanti gli si paravano davanti. L'assalto ingiustificato e violentissimo contro uomini inermi produsse subito 2 morti e numerosi feriti, ricoverati nell'ospedale dei Pellegrini, dove nei giorni successi morirono altri feriti gravi. Il bilancio complessivo della mattanza conta alla fine 7 morti e 20 feriti.
Le autorità e la stampa cercarono di dare il minimo risalto all'eccidio, riducendolo ad un incidente deprecabile, purtroppo provocato da "mestatori borbonici". In prima linea in quest'opera di minimizzazione, il questore Nicola Amore, che, peraltro, convocò ed intimidì pesantemente l'impiegato Antonino Campanile, testimone dell'evento, che nella deposizione resa nell'immediato alla polizia, aveva negato che gli operai avessero tenuto un atteggiamento minaccioso e tanto meno adottato comportamenti violenti, che, al contrario, erano venuti solo dai bersaglieri. Ciononostante, il Campanile, con schiena dritta, non ritrattò la sua testimonianza, pagando per questo un caro prezzo: l'azienda nei suoi confronti, per ritorsione, aprì prima una procedura disciplinare e poi lo licenziò.
Il questore, al contrario, per la sua compiacente ed indegna condotta, ebbe la riconoscenza dei superiori e, di lì a poco, la poltrona di Sindaco di Napoli.
Dopo l'eccidio, Bozza rinunciò alla concessione e la fabbrica fu più volte trasferita a varie società ed enti che non si presero più cura di fare investimenti ed ammodernamenti degli impianti, così da creare le premesse e la giustificazione della decisione di farne non più un'officina di produzione ma solo di manutenzione di locomotive delle ferrovie, fino alla scelta di chiuderla nel 1975.
Il Real Opificio di Pietrarsa, restaurato, è stata riaperto nel 1982 come museo ferroviario.
Pur con tutte le ingiuste penalizzazioni che stava subendo, nel 1862, all'esposizione internazionale di Londra, la fabbrica ricevette la "menzione onorevole" e la medaglia d'oro per la produzione di una locomotiva con ornamenti in ghisa. Così nel 1873 all'esposizione universale di Vienna: medaglia d'oro per la produzione di una locomotiva per treni merci.
Fu l'ultimo canto di un cigno, ucciso non dalla concorrenza in un libero mercato, secondo la dottrina liberale della quale, a parole, si dicevano scrupolosi osservanti i governanti italiani - da Cavour ai suoi successori - ma proprio da essi che, tradendo gli interessi della nazione ed abusando invece del potere esecutivo nelle loro mani, se ne servirono per eliminare, prima ancora della gara, il formidabile e temuto concorrente dell'impresa che avevano interesse personale e di gruppo a favorire.
Una vicenda illuminante e paradigmatica che dimostrò subito di che pasta fossero (e sono) fatti i capitalisti ed i liberali di questo nostro sventurato Paese.
Questo lungo racconto vuole in parte rievocare la esemplare storia della deliberata distruzione di un polo industriale di eccellenza del Sud con l' intento di favorire la ancora fragile industrializzazione del centro-nord (al 1860), nell'assoluta indifferenza per la condizione di miseria, dolore ed emigrazione alla quale si condannavano le genti meridionali, dopo averne deviato il destino.
Ma il racconto, oggi soprattutto, non può prescindere dal ricordo della cinica distruzione che coinvolse, con Pietrarsa, la vita di poveri operai, colpevoli solo di protestare civilmente per difendere il diritto al lavoro ed al salario e che il neonato stato non tutelò come doveva ma soffocò nel sangue.
E' il primo caso di cruenta repressione di una lotta operaia non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo occidentale.
Bisogna infatti aspettare il 3 maggio del 1886 per registrare un caso analogo a Chicago, quando la polizia uccise 2 operai e ne ferì altri per reprimere un assembramento di lavoratori in sciopero davanti alla fabbrica di macchine agricole McCormik.
Quando tuttavia nel 1889 a Parigi si riunì la Seconda Internazionale, si decise di ufficializzare la data del 1° maggio come giorno di festa dei lavoratori per onorare il ricordo dei caduti di Chicago.
Non è incredibile che dei morti operai di Pietrarsa, dopo 13 anni, si fosse già persa la memoria ?
Sono un appassionato di storia ed ho letto molti libri, anche sul movimento operaio: in nessuno ho trovato traccia dell'eccidio di Pietrarsa di cui oggi ricorre l'anniversario.
Ho militato da giovanissimo nel PCI e, successivamente, nella CGIL, anche con qualche responsabilità ed ho perciò per molti decenni partecipato attivamente alle feste del 1° Maggio tenutesi a Napoli, la mia città natale. In nessuna delle manifestazioni in cui si articolano queste feste e se ne esprimono i contenuti (cortei, striscioni, parole d'ordine, volantini, comizi, concerti) ho mai sentito ricordare gli operai napoletani uccisi il 6.8.1863 per mano dello stato sul loro posto di lavoro, mentre erano in lotta per i loro diritti.
Non una dimenticanza, bensì una rimozione che certo tradisce la ovvia volontà del neostato italiano di occultare un infame crimine da lui stesso perpetrato, in coerente continuità con la sua nascita dall'inganno, dalla rapina, dall'usurpazione, e dall'assassinio delle inermi popolazioni del Sud.
Una rimozione che purtroppo tradisce pure la imbarazzante vergogna di un movimento operaio nato e radicato al nord, insieme al capitalismo italiano -col quale ha convissuto e convive anche fisicamente- e che ha partecipato e partecipa obiettivamente -al di là delle enunciazioni formali- ai frutti della spoliazione che il capitalismo italiano ha fatto e fa del Sud dalla sua annessione, inclusi gli effetti del soffocamento in culla del proletariato meridionale ("mors tua vita mea").
Un giudizio che forse a qualcuno non piacerà. Me ne dispiace per lui, ma io cerco solo di attenermi ai fatti.
Ed è un fatto che tutti ignorano che una delle vittime degli "eroici" bersaglieri si chiamava Aniello Olivieri ed era solo un ragazzo di 14 anni, ma non ebbe paura di morire per i suoi diritti: dei 7 morti è l'unico raggiunto dai proiettili in pieno petto.
Un giovanissimo ed esemplare operaio che nessuno in questo paese (istituzioni, partiti e sindacati) ha mai ricordato e onorato, come altrove meriterebbe e sarebbe logico, tanto meno il 1° maggio, quando si preferisce ricordare gli operai uccisi oltre-atlantico, piuttosto che quelli ammazzati sotto casa dal nostro stato, anche per evitare il rischio che, collegandoli alla apparentemente dissennata scelta di dismettere una fabbrica modello del Sud, si aprirebbero troppi scomodi e spiacevoli squarci di consapevolezza.
Ed è un altro fatto che il "carnefice" di Aniello o, comunque, il maggiore responsabile dell'eccidio di Pietrarsa, Nicola Amore (scherzi dei cognomi), viene ricordato quotidianamente dai napoletani perché a lui -lui sì, benemerito della nazione !- è dedicata una delle più centrali e nevralgiche piazze del centro storico di Napoli.
E' questa la patria che dovremmo amare ed onorare ed alla quale dovremmo sentirci orgogliosi di appartenere ?
P.S. Onore a quanti oggi, distogliendosi dai loro impegni e sfidando il caldo, si recheranno a Pietrarsa per ricordare l'eccidio.
Onore al sen. Sergio Puglia (M5S) che in questo giorno, un anno fa, nell'aula sorda e distratta del Senato, ruppe un vergognoso silenzio di 150 anni su una vicenda colpevolmente rimossa dalla coscienza assopita di una collettività retta da una Costituzione che, all'art. 1, retoricamente proclama che il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica democratica.


Il tecnico delle vespe si congratula con la squadra di Conte e commenta la vigilia della semifinale play-off di ritorno. «A Cremona partita difficile, dobbiamo fare 98 minuti con il casco in testa, senza abbassare i ritmi. Fortini? Non condivido il suo post sui social»


